
Mi stanno arrivando tante segnalazioni di persone che hanno letto i libri che ho recensito e di altre che vorrebbero che scrivessi di libri che hanno letto o che vorrebbero leggere. Il blog funziona!!! E vi ringrazio tanto.
Il libro di oggi “Non superare le dosi consigliate” mi è stato segnalato da Elena, collega con cui condivido ogni tanto viaggi da e per la Svizzera. Lettrice accanita! Che ringrazio!
“Non c’è un problema che un farmaco non curi, mamma lo dice sempre. A casa nostra non si parla, si prendono medicine. Così lei mi dà il Dulcolax ogni sera perché sono una bambina grassa. Due compresse, quattro, otto. E io non so che legame ci sia tra il Dulcolax e una bambina grassa visto che non dimagrisco….”. C’è un peso che non puoi perdere, anche quando l’hai perso tutto. Matilde lo sa: la mamma, bulimica, passa le giornate a vomitare; lei ha cominciato a ingrassare quando aveva sei anni ed è affamata da una vita. A scuola elemosina biscotti, a casa ruba il pane, e intanto sogna che gli taglino la mano. Ottanta chili a sedici anni, a diciotto quarantotto; Matilde va in America a studiare, splende, ma la fame e la paura le vengono dietro. Finchè dopo la morte della madre, il tracollo finanziario del padre e una relazione violenta, supera i centotrenta chili. E quando esce, c’ è sempre qualcuno che la guarda con disprezzo. Allora Matilde si chiude in casa per tre anni, e suoi social si finge normale. Ma che vuol dire normale? Un romanzo crudo e potente tra due lingue e due culture, tra gli anni Settanta e oggi. Un libro vorticoso tra perfezionismo, autolesionismo, menzogna e dipendenze.
Succede spesso che io inizi le mie recensioni riportando le presentazioni scelte dalla casa editrice. E poi mi capita di fare delle ricerche qua e là: l’uscita del libro è stato preceduto da un articolo scritto dalla stessa autrice e apparso su “7” il supplemento del Corriere della Sera, dal titolo “Storia della mia grassezza ( e di come ho deciso di non abbozzare più)”. Sull’onda del grandissimo interesse nato per il pezzo, a romanzo già scritto, ne è nata anche una rubrica.
Ho trovato moltissimi contributi, di donne che si sono identificate, che dichiarano che avrebbero potuto scrivere la stessa storia e altre che, al contrario, dicono di aver capito poco di questa donna. Che si tratta di uno scritto irto di ostacoli, ripetitivo, che sono 250 pagine che lasciano il lettore esausto. Altre che, in riferimento alla protagonista Matilde, dichiarano che non conquista, che non lega a sé, che non riesce a far empatizzare con il suo dolore. Che non trasmette, che non lascia nulla a chi la incontra e che anzi ci si dimentica di lei appena si termina la lettura, con la sensazione di essere finalmente liberi.
Per quanto mi riguarda, sono altre le considerazioni che voglio condividere con voi.
A pagina 35, l’autrice fa una citazione che torna spesso nel corso del romanzo: Innocence, or ignorance, direbbe Alice Munro nel racconto che ha segnato la mia vita, An Ounce of Cure. Mi sono incuriosita. Il racconto di cui parla si trova nella raccolta “Danze delle Ombre felici” della Munro, nella traduzione italiana il titolo è Il rimedio. Poco più di 10 pagine. Parla di una ragazzina, adolescente, di indole spinosa. Di una casa in cui non si beve, o meglio si beve fuori. E di un rapporto con la madre per la quale l’ignoranza o l’ innocenza se preferisci, non è sempre la meraviglia che la gente crede, e ho paura che potrebbe rivelarsi un pericolo per una come te. Nel racconto, la protagonista vive una delusione d’amore e mesi di autentica disperazione seppure in larga misura autoinflitta. La madre, che si accorge che qualcosa non va, le compra dei ricostituenti a base di ferro, le chiede della scuola. Una sera, impegnata come baby sitter, a contatto con sentimenti di solitudine e tristezza, la ragazza si ubriaca, sta male, la scoprono, la rimproverano, la riportano a casa. Per tutti irresponsabile, le sue tristezze vengono usate dalla madre per non fare brutta figura con i vicini. Ci fu però un risvolto positivo e meravigliosamente inatteso in questa vicenda (….) Che cosa fu dunque a riportarmi coi piedi per terra? Fu la tangibilità atroce e ammaliante del mio disastro; fu vedere “come andavano le cose”. Non che mi fosse piaciuto; ero timida e tutta quella risonanza mi fece soffrire molto. Ma il concatenarsi dei fatti di quel sabato sera mi affascinò; ebbi la sensazione di aver gettato un’occhiata sulla prodigiosa, devastante e spudorata assurdità con cui si improvvisano le trame della vita, a differenza di quelle dei romanzi. Non riuscivo a distogliere lo sguardo. E, a proposito dell’ultimo incontro con il ragazzo oramai adulto: Notai che mi stava guardando con l’espressione più simile a un sorriso memore che le circostanze permettessero. E capii che lo aveva sorpreso il ricordo vuoi della mia devozione, vuoi del mio modesto scheletro nell’armadio. Ricambiai con un’occhiata cortese e priva d’intesa. Sono una donna adulta, ormai; ciascuno si dissotterri i propri, di scheletri.
In generale, per rimedio s’intende un farmaco o un trattamento medico indicato per alleviare o combattere una malattia. Provvedimento più o meno efficace, diretto a sanare una condizione negativa o sfavorevole. Alleviare, combattere, sanare. Di comprendere non vi è traccia.
Penso alla protagonista del racconto della Munro che vede gli adulti bere dell’alcool prima di uscire, erano tutti piuttosto allegri. Li vede traccannare gli aperitivi come fossero bibite. E penso a come spesso, quando entriamo in contatto con sofferenze e vissuti di tristezza, in maniera un po’ infantile, facciamo quello che vediamo fare agli altri. Per uscire anche noi piuttosto allegri (innocence or ignorance). E penso alla protagonista Matilde che vede la mamma vomitare, che la vede prendere del Dulcolax, che la chiama cretina, che le da lo stesso lassativo perché è grassa. L’alcool e il cibo, il vomito e i lassativi come rimedio.
Per tutta la lettura di “Non superare le dosi consigliate” mi sono domandata cosa abbia spinto l’autrice a scrivere questa storia, quelle 250 pagine piene di parole, di cose che accadono, che stancano, che quasi ti allontanano per quanto sono vere, dirette e piene di dolore.
Mi sono detta se non fosse proprio nel tentativo di passare da quell’ innocence or ignorance a, come alla fine del racconto della Munro, “vedere come andavano le cose”. Comprenderle. Promuovendo anche nel lettore la spinta a farsi domande, a cercare di comprendere, creare legami di senso.
Perché un rimedio senza comprensione non porta al cambiamento. A crescere. A dissotterrare i propri scheletri nell’armadio. Perché gli scheletri possano riposare in pace. Nel posto giusto.
Il segnalibro, un’ironica caricatura….
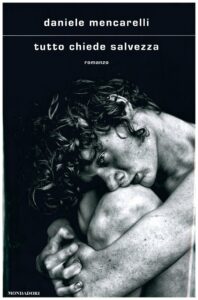

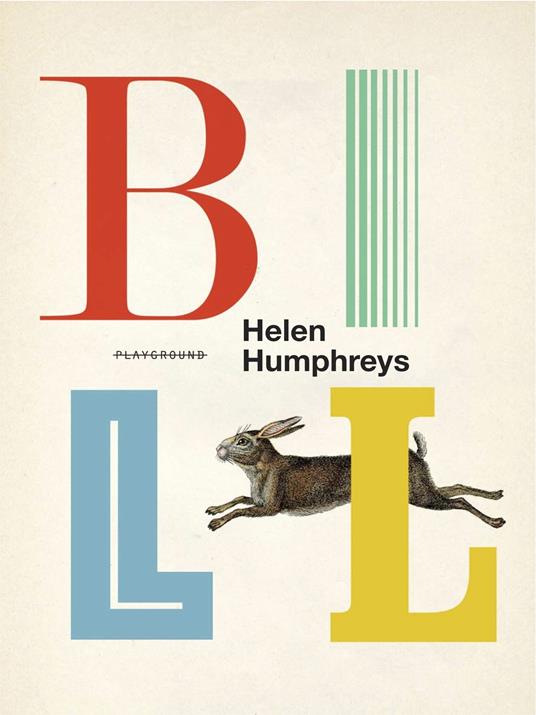

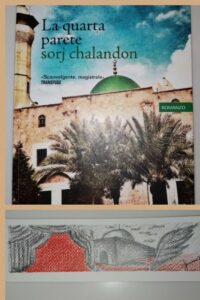



Seguimi su