

L’emozione per questa recensione va al di là del libro: si tratta della prima lettura nata dalla segnalazione di una lettrice del blog. Un’amica lettrice. Ti ringrazio Marilena per aver compreso il senso di questo blog: i libri come occasione di scambio, riflessioni condivise e scambio di emozioni!
Spero e attendo altri consigli di lettura da tutti voi!!!!!
E ora veniamo al libro. La trama in breve: in un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato Totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. Offred ha solo un compito nella neonata Repubblica di Gilead: garantire una discendenza all’èlite dominante. Il regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle cosiddette Ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo stato più repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo dipenderà la possibilità e, forse, il successo di una ribellione.
Ho iniziato questo libro e dopo una decina di pagine mi sono fermata. Per un mese. Il razionale era “questo genere non fa per me”, in realtà era soltanto il tentativo di allontanare quella sgradevole sensazione di qualcosa che non ha tempo, ma che comunque, ti tocca. Ti riguarda. Non è un genere, è il tentativo di mascherare qualcosa che può riguardare tutti. Ieri, oggi e domani.
Viene definito un libro distopico. Per distopia, o anche antiutopia, si intende un libro che descrive o rappresenta uno stato futuro di cose che, in contrapposizione all’utopia, presenta situazioni e sviluppi sociali, politici e tecnologici altamente negativi, in genere indica un’ipotetica società (spesso collocata nel futuro) nella quale alcune tendenze sociali, politiche e tecnologiche percepite come negative o pericolose sono portate al loro limite estremo.
L’ho ripreso durante un viaggio in treno di ritorno dalle vacanze di Natale e non è stato possibile smettere, nonostante permanesse quel senso di disagio: qualcosa di impossibile che non lo era del tutto, che tentava di essere impersonale e freddo ma che poi ti coinvolgeva con emozioni, sentimenti, ricordi.
Il libro viene raccontato in prima persona, della protagonista arriviamo a conoscerne il nome soltanto a pag. 266 e questo ti porta inevitabilmente a identificarti. Offred. Perché di Fred. Non il suo vero nome, ma quello stabilito dalla Repubblica di Gilead. Offred. Of Fred. Di Fred. Appartenente a Fred.
Alcune parti ti costringono a fermarti. Crude verità.
“Noi abbiamo dato loro più di quanto non abbiamo tolto” dice il Comandante. “pensate alla situazione in cui si trovavano prima, pensate ai bar per donne sole, all’indegnità degli appuntamenti a sorpresa. Era il mercato della carne. Non ricordate il terribile divario tra coloro che potevano avere un uomo facilmente e quelle per le quali era impossibile? Alcune di loro, prese dalla disperazione, deperivano per dimagrire, altre si gonfiavano i seni col silicone, altre ancora si facevano tagliare il naso. Quanta infelicità!” Accenna, agitando una mano, a una pila di vecchie riviste.
“Si lamentavano sempre. Problemi di qui, problemi là. Vi ricordate delle colonne di annunci personali? Vivace, graziosa, trentacinquenne….in questo modo un uomo lo trovavano, ma poi, se si sposavano, spesso restavano sole, con un figlio o due perché il marito, stanco di loro, scompariva, così che si trovavano costrette ad affidarsi alla pubblica assistenza. Oppure, se avevano un lavoro, dovevano lasciare i figli al doposcuola o affidarli a qualche donna ignorante e brutale, che dovevano pagare loro stesse, sottraendo il denaro alle loro misere buste paga. Il denaro era l’unica misura del valore, per tutte, l’essere madri non dava diritto al rispetto. Non c’è da meravigliarsi quindi che stessero addirittura rinunciando alla maternità. Ora, invece, sono protette, possono adempiere in pace ai loro destini biologici, con pieno sostegno e incoraggiamento. Adesso, ditemi il vostro parere, siete persone intelligenti, vorrei sapere che ne pensate. C’è qualcosa che abbiamo trascurato?”
“L’amore” rispondo. “l’innamorarsi….”
Questo scambio, quello più significativo del libro, va avanti e descrive la vita a Gilead: parla di autorità maschile, della necessità di sottomettersi all’autorità maschile. Alla maternità come possibilità di salvezza. Dal peccato originale. All’amore. Alle donne che amavano. E che si sentivano libere di cambiare. Senza limiti. E alla condanna alla fissità. Che apre necessariamente a ciò che è necessario nascondere. Le prostitute. Le donne nel club.
E in testa alcune domande del mio presente: cosa c’entra la libertà con l’assenza di limiti? Cosa c’entra l’amore con l’assenza di limiti? Cosa significa sentirsi libera?
E nelle pagine finali, quelle in cui vengono riportati gli atti del simposio del 2195 in cui storici partendo da Il Racconto dell’Ancella, quale testimonianza storica e diretta, si confrontano sull’organizzazione di Gilead:
“Come abbiamo sentito durante la discussione del comitato di esperti, Gilead, sebbene indubbiamente patriarcale nella forma, fu saltuariamente matriarcale nel contenuto (….) Come gli artefici di Gilead ben sapevano, per istituire un sistema totalitario efficace o invero un qualsiasi sistema è necessario offrire qualche beneficio e qualche libertà, almeno a pochi privilegiati, in cambio di ciò che viene loro tolto. A questo proposito è opportuno un commento sull’organizzazione femminile di controllo nota come le Zie. Judd, era dell’opinione fin dall’inizio che fosse più efficace ed economico far controllare le donne, a scopi riproduttivi e altro, a opera delle stesse donne. Non mancavano i precedenti storici; infatti in qualsiasi impero, imposto con la forza o in altro modo, il controllo degli indigeni è sempre stato effettuato da membri del loro stesso gruppo. Nel caso di Gilead, c’erano molte donne desiderose di coprire il ruolo di Zie, sia a causa di un’autentica fiducia in ciò che chiamavano “valori tradizionali”, sia per i benefici che potevano trarne. Quando il potere è scarso, averne anche solo un poco costituisce una tentazione. C’è un altro incentivo: donne senza figli o sterili o anziane, che non fossero sposate, potevano prendere servizio nei ranghi delle Zie e quindi sfuggire al rischio del sovrannumero e al conseguente invio per mare alle infami Colonie, che erano costituite da popolazioni mobili usate soprattutto per la rimozione di materiale tossico, anche se, con un po’ di fortuna, si poteva venire assegnati a compiti meno rischiosi, quali la raccolta del cotone o della frutta”.
Mi sono domandata quale fosse il significato profondo del termine matriarcato e a scoprire che nel mondo oggi esistono oltre cento società matriarcali. Una società matriarcale è una comunità di persone basata sulla centralità della figura femminile. Luoghi dove non è necessaria una “Festa della mamma”, perché la maternità e la femminilità sono celebrate ogni giorno. Queste società, che oggi è possibile rinvenire soprattutto in Asia, nelle Americhe e in Africa corrono il serio rischio di sparire sotto la forte spinta della globalizzazione. In alcuni testi, viene riportato che il loro valore non è soltanto storico (alcune di queste organizzazioni vantano una tradizione millenaria), anche perché la loro struttura politica, economica, sociale e spirituale può essere di grande importanza per noi occidentali, in quanto ci insegna a organizzare e promuovere società non violente e mutuali, dove le donne sono al centro dell’ordinamento sociale, ma non per questo ricorrono a forme di dominio per guidare la propria comunità. Ecco il punto, spesso si confonde il matriarcato con l’idea di “dominio della donna”. In realtà, in siffatte organizzazioni sociali, ci si basa su una vera e propria partnership uomo-donna, che continua a tener vivo un diverso modello di civiltà per donne e uomini. Ora mi è più chiaro: patriarcato o matriarcato, poco cambia quando la logica è quella del dominio.
Nelle pagine conclusive, negli atti del Dodicesimo Simposio di Studi Gileadiani del 2195 vengono citate le opere del relatore tra cui Iran e Gilead: due Monoteocrazie del Tardo Secolo Ventesimo viste attraverso i diari. Il libro è stato scritto nel 1985, letto da me nel 2020, lo studio futuristico del 2195.
La sensazione che poco o nulla sia cambiato. Vorrei che questo libro fosse letto per far nascere domande e riflessioni. Forse è più un libro da donne, per donne. Ne vale la pena.
Il segnalibro, una figura ambigua, uomo o donna? Chi comanda nella Repubblica di Gilead: uomini sulla carta ma donne nella sostanza. Chi domina e chi viene dominato?










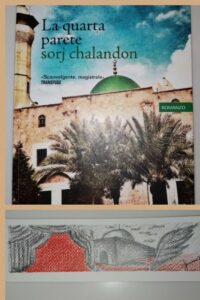




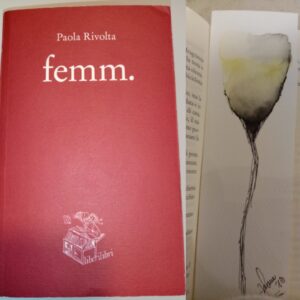
Seguimi su